 Kibaigwa:
la scuola non è più un sogno
Kibaigwa:
la scuola non è più un sogno
Presentiamo in anteprima un racconto della nota scrittrice Dacia Maraini che insieme ad altri numerosi e famosi artisti ha gentilmente collaborato ad un’opera di prossima pubblicazione a cura del nostro Centro Missionario
Padre
Corrado mi parla di un Centro di accoglienza per studentesse povere a
Kibaigwa. Io dico subito che l’idea mi piace. Di fronte alle mille
discussioni sugli annosi e gravissimi mali dell’Africa mi conquistano
le persone che si rimboccano le maniche e cercano di dare una mano subito,
ora, regalando generosamente il proprio tempo, la propria fiducia, le
proprie energie.
Studentesse povere. L’Africa ne è piena. Le ho viste camminare,
a piedi scalzi, facendo chilometri su chilometri per raggiungere la scuola
più vicina. Le ho viste sorridere e salutare, spingendosi sui bordi
della strada, incuranti della polvere che le avrebbe ricoperte da capo
a piedi, quando passavano le rare automobili. Qualche camioncino magari
si fermava, per dare loro un passaggio. E le ragazze montavano sugli alti
predellini impacciate dal largo kanga che fascia loro i fianchi e le gambe
ed è il solo indumento che usino nei paesi dell’interno. Senza
un dubbio, un sospetto. Nell’Africa interna generalmente le persone
sono ben disposte, pronte a dare fiducia allo straniero. E’ la cultura
contadina, abituata ai piccoli centri in cui tutti si conoscono e si chiamano
per nome che porta a queste aperture. Mentre nelle città il clima
è già diverso: anche i bambini sanno che ci sono i malintenzionati
e ti guardano con sospetto se mostri di interessarti a loro.
Nelle città perfino gli indumenti delle studentesse cambiano: spesso
portano le scarpe, magari di gomma, ritagliate nei copertoni dei camion,
o di rafia importate dalla Cina a poco prezzo, indossano una gonnellina
a pieghe lavata e rilavata, una camicetta bianca e un fiocco blu notte
che gira intorno al colletto e si allaccia sul petto. Portano con orgoglio
una cartellina plastificata e un recipiente con delle fette di banane
fritte per uno spuntino a metà mattina.
Spesso nelle zone interne più povere le uniche scuole sono quelle
delle missioni. Immagino che Kibaigwa sia uno di questi villaggi poveri
che non dispongono nemmeno di una scuola di volontari. Un villaggio sul
bellissimo altipiano della Tanzania, a un’ora di viaggio dalla nuova
capitale Dodoma, così mi ha spiegato padre Corrado.
Immaginiamo una bambina di dieci anni che chiameremo Berah. In effetti
ho conosciuto una bambina di questo nome tanti anni fa viaggiando per
gli altipiani della Tanzania. Ora questa bambina avrà quasi trent’anni
e certamente sarà madre e forse perfino nonna. Spero che sia scampata
al terribile male che sta uccidendo tanti innocenti africani. Parlo dell’AIDS
che si propaga a macchia d’olio per l’assoluta impossibilità
degli africani, poverissimi, a prevenirla. Perfino un preservativo è
troppo caro per una coppia di amanti. E che dire di quelle Case Farmaceutiche
le quali si rifiutano di abbassare i prezzi dei loro medicinali salvavita
in un paese che sta letteralmente morendo di questo male? In molti paesi,
che per fortuna non sono la Tanzania, si conta il trenta per cento di
malati di AIDS che non possono curarsi e sono destinati a morire in poco
tempo. Una ecatombe.
Ma torniamo a Kibaigwa e alla sua bambina Berah, che ogni mattina si mette
in moto alle quattro, quando è ancora buio pesto, per andare a
scuola in un villaggio a cinque chilometri di distanza.

Berah
abita in una capanna con la madre e quattro sorelle più piccole.
Nelle capanne vicine alloggiano le altre mogli del padre, ciascuna con
tre o quattro bambini. Il padre, contadino, ha come abitazione una capannuccia
solitaria un poco discosta dalle casupole delle mogli che sono accomodate
a cerchio, all’interno di un recinto di pietre bianche. La famiglia
di Berah è composta da un uomo sui cinquant’anni e dalle sue
tre mogli che lavorano i campi per lui. Al padre tocca la semina del miglio,
spetta la decisione di quando comprare il sale e il sapone al mercato
della domenica, compete il controllo del buon andamento della comunità,
nonché la responsabilità del comportamento delle mogli e
dei figli. Alle donne appartiene invece il lavoro dei campi, il trasporto
della legna per cucinare, la raccolta del miglio, la fabbricazione della
birra che richiede giornate intere di bollitura, la battitura dell’ignam
che si fa cantando nell’aia comune, la preparazione del cibo e la
vendita dei prodotti al mercato. Inoltre ogni donna si occupa dei suoi
bambini e cerca di smorzare ogni lite o rivalità con i figli delle
altre mogli.
La madre di Berah è giovane, ma già sciupata dalle tante
gravidanze e allattamenti. Anche in questo momento tiene un bambino al
seno mentre cucina all’aperto su un fuoco acceso fra sassi ammucchiati.
In Africa le donne tengono i figli al seno anche fino a tre anni, perché
hanno paura di dare loro da bere l’acqua che quasi sempre è
inquinata. Il passaggio dal latte all’acqua è il momento più
drammatico per un piccolo africano. Ed è proprio in questo passaggio
che tanti bambini muoiono.
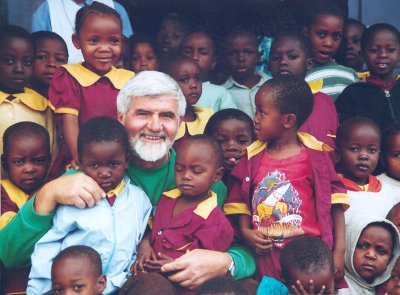 Ma
nonostante queste minacce e questi pericoli, Berah non ha mai sentito
la giovane madre lamentarsi o mostrare una faccia lunga e immusonita.
Al contrario è allegra e pronta al riso. Ride della pentola che
si rovescia sul fuoco, anche se oggettivamente si tratta di un dramma
perché l’acqua bisogna andarla a prendere a due chilometri
di distanza presso una fonte sempre affollata dove si fa la fila anche
per un’ora. Ride perché l’ultimo nato ha starnutito facendo
una smorfia buffa. Ride perché una delle figlie femmine si è
strappata il kanga su un fianco e non trova l’ago per ripararlo.
Ride perché una vicina sta litigando con il marito. Ride perché
la pecora legata al paletto vicino casa sta cercando di dare delle testate
ad un bambino che cammina a quattro zampe, prendendolo per un agnellino.
Ma
nonostante queste minacce e questi pericoli, Berah non ha mai sentito
la giovane madre lamentarsi o mostrare una faccia lunga e immusonita.
Al contrario è allegra e pronta al riso. Ride della pentola che
si rovescia sul fuoco, anche se oggettivamente si tratta di un dramma
perché l’acqua bisogna andarla a prendere a due chilometri
di distanza presso una fonte sempre affollata dove si fa la fila anche
per un’ora. Ride perché l’ultimo nato ha starnutito facendo
una smorfia buffa. Ride perché una delle figlie femmine si è
strappata il kanga su un fianco e non trova l’ago per ripararlo.
Ride perché una vicina sta litigando con il marito. Ride perché
la pecora legata al paletto vicino casa sta cercando di dare delle testate
ad un bambino che cammina a quattro zampe, prendendolo per un agnellino.
Berah sa che la madre preferirebbe che lei rimanesse a casa a preparare
la birra di miglio e a battere l’ignam anziché andare a scuola,
ma sa anche che la figlia è cocciuta e quando si mette in mente
una cosa è difficile farle cambiare idea.
Così Berah va a dare un bacio al padre che si è appena svegliato
e sta fumando la pipa che si è costruito con le sue mani e quindi
si avvia verso la scuola. Dovrà camminare per chilometri nella
semioscurità. Ma avrà il piacere di vedere spuntare il sole
che illuminerà gli alberi e succhierà l’umidità
della notte dal terreno rossiccio e pieno di crepe. Lungo il cammino incontrerà
gli operai che stanno preparando la nuova strada. Li saluterà con
un cenno del capo e loro la guarderanno camminare con un misto di orgoglio
e di invidia: nessuno di loro ha avuto la possibilità di frequentare
la scuola.
Berah è puntualissima. Arriva alla scuola proprio nel momento in
cui il giovane maestro dalla piccola testa ricciuta e gli occhi grandi
e affettuosi, sta aprendo le porte delle aule. Il pavimento è di
cemento, sopra stanno ritti, allineati, una trentina di banchi sgangherati
di legno vecchio tutto intagliato e intarsiato, con i nomi incisi perfino
sulle zampe. C’è una grossa lavagna in piedi su un cavalletto
storto. Sulla parete si apre una finestra senza vetri da cui entra la
polvere della strada, lo stridore delle cicale e il vociare dei bambini
che si affollano sull’ingresso.
Berah è molto amata dal maestrino giovane e ricciuto perché
impara subito e bene, perché non passa le mattinate a ridere o
a tirare palline di carta come fanno molti altri studentelli. Perché
ha voglia di imparare e di capire. Quando il maestro sciorina davanti
agli occhi dilatati dei suoi alunni la carta della terra, Berah rimane
esterrefatta. Non pensava che il mondo fosse così grande e così
diverso. Il maestro che si chiama Ahmed ha anche mostrato loro delle grandi
fotografie a colori di una città lontana chiamata Roma. In questa
città c’è un circo gigantesco che si chiama Colosseo
dove i romani davano i cattolici da mangiare ai leoni. Berah conosce i
leoni, ne ha visto uno anni fa, sfregiato, che si leccava la ferita sdraiato
al sole. Ogni tanto vengono i turisti, pagano un tanto e se ne vanno in
giro con il fucile a uccidere i grossi animali. Ora, dice il maestro,
non ci sono più leoni a Roma. In compenso ci sono tante macchine,
rosse, blu, gialle, che corrono in lungo e in largo e mandano tante nuvolette
che arrivano fino in Africa e puzzano di gas cattivo.
 Il
maestro Ahmed sa che Berah viene da un villaggio a cinque chilometri di
distanza e quando vede la bambina entrare nella scuola le guarda i piedi
con commiserazione. Fra i calli induriti e impolverati si vedono le croste
delle ferite recenti: i sassi appuntiti, i pruni dalle punte acuminate,
i pezzi di vetro nascosti nella polvere procurano spesso dei tagli e dei
graffi sulle gambe e sui piedi della bambina. Ogni tanto una caviglia
si gonfia e la fa zoppicare. Ma per fortuna Berah è robusta e dopo
un poco anche il piede ferito guarisce e lei riprende la strada con il
piglio di una brava scolara. Il maestro vorrebbe regalarle un paio di
scarpe ma dove trovare i soldi? il suo stipendio è talmente misero
che non basta neanche a pagare il cibo per sua madre e i suoi otto fratelli
che vivono nella periferia di Dodoma, in una baracca dal tetto di bandone,
senza cesso e senza acqua corrente.
Il
maestro Ahmed sa che Berah viene da un villaggio a cinque chilometri di
distanza e quando vede la bambina entrare nella scuola le guarda i piedi
con commiserazione. Fra i calli induriti e impolverati si vedono le croste
delle ferite recenti: i sassi appuntiti, i pruni dalle punte acuminate,
i pezzi di vetro nascosti nella polvere procurano spesso dei tagli e dei
graffi sulle gambe e sui piedi della bambina. Ogni tanto una caviglia
si gonfia e la fa zoppicare. Ma per fortuna Berah è robusta e dopo
un poco anche il piede ferito guarisce e lei riprende la strada con il
piglio di una brava scolara. Il maestro vorrebbe regalarle un paio di
scarpe ma dove trovare i soldi? il suo stipendio è talmente misero
che non basta neanche a pagare il cibo per sua madre e i suoi otto fratelli
che vivono nella periferia di Dodoma, in una baracca dal tetto di bandone,
senza cesso e senza acqua corrente.
Una mattina Berah, uscendo dal suo villaggio, incontra degli operai nuovi.
Che state facendo? chiede loro. Un ragazzino dal berretto infilato alla
rovescia, tutto impolverato di calce, le racconta che sono venuti i Cappuccini
Toscani e hanno cominciato a costruire una scuola a Kibaigwa. Davvero?
ma cosa vuol dire cappuccini? E chi lo sa? risponde sorridendole il ragazzino
e torna al suo lavoro.
La sera stessa Berah saprà dal padre che i cappuccini si chiamano
così perché portano il cappuccio. Che sono ‘dei figli
di Dio che regalano la propria vita agli altri. Qualche volta sono gentili
e generosi, qualche volta sono anche urloni e comandoni, come tutti gli
uomini della terra’, dice l’uomo saggiamente fumando la sua
pipa. Berah batte le mani per la contentezza: finalmente potrà
alzarsi alle sette anziché alle quattro, potrà fare riposare
i suoi piedi feriti, potrà trovarsi fra amici e parenti nelle aule
di una scuola tutta nuova. La sola cosa che le dispiace è di lasciare
il maestro Ahmed che è sempre stato così gentile con lei.
Ma quale non è la sua sorpresa nell’apprendere, qualche giorno
dopo, che il maestro Ahmed verrà a insegnare a Kibaigwa, proprio
lì, nella scuola nuova. Perché nel villaggio vicino è
arrivato un altro insegnante e lui non ha più lavoro. I cappuccini
gli hanno chiesto di venire nella loro scuola nuova ed è stata
proprio Berah a trovargli questo lavoro mostrando quanto aveva appreso
da lui.
Questo era il sogno di una scrittrice che lavora con l’immaginazione.
Fuori dal sogno, da questa lontana Italia, la scrittrice augura ai cappuccini
missionari in Africa di riuscire nel loro intento di costruire una bella
e capiente scuola nel piccolo villaggio di Kibaigwa.q